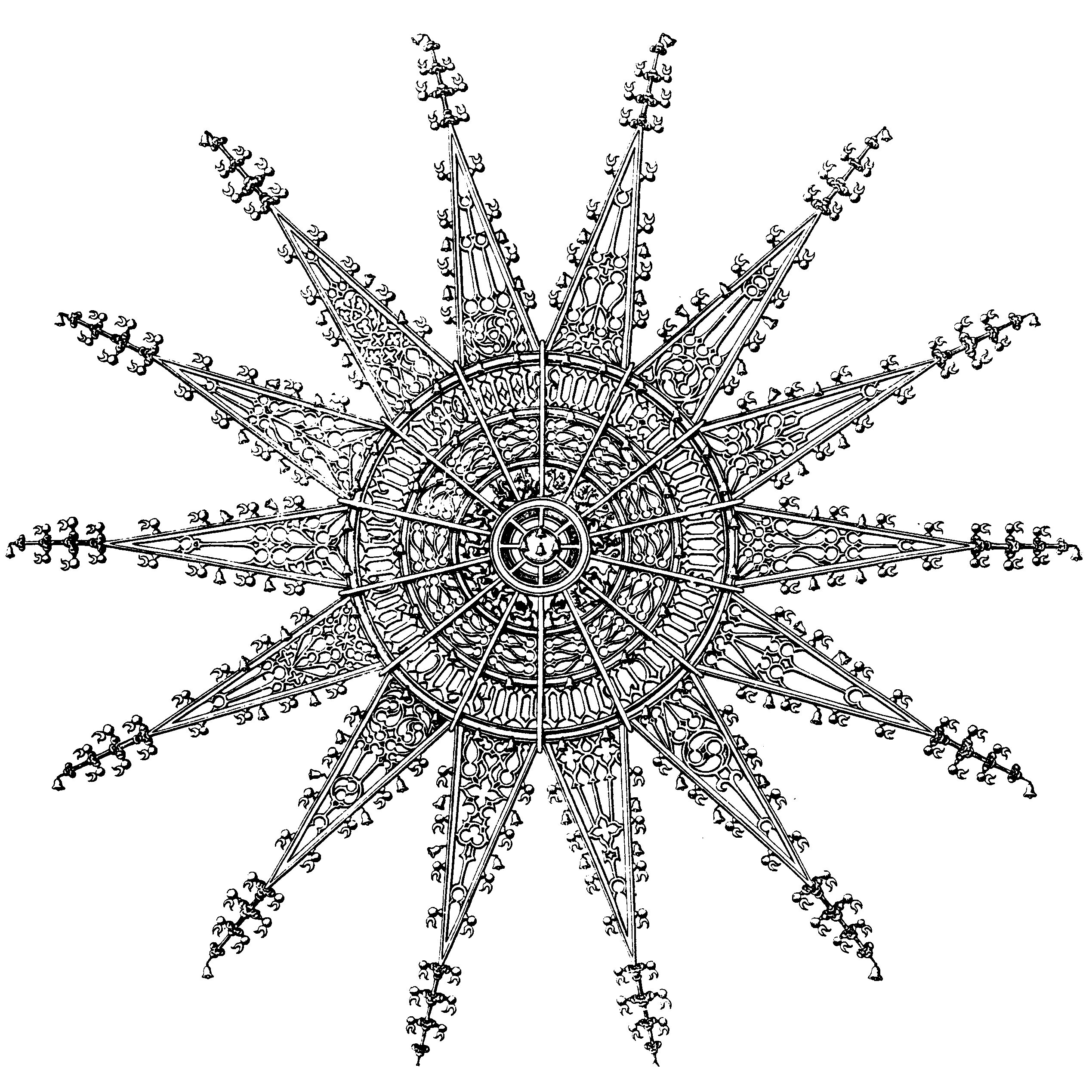Di fronte ai continui inviti delle autorità accademiche a procedere ad accorpamenti e riorganizzazioni degli ordinamenti didattici ho ricontrollato di recente le tabelle ministeriali per le classi di laurea magistrali. Ho (ri)scoperto che il settore L-ART/08 – Etnomusicologia non è presente come materia “caratterizzante” né in Lettere, né in Scienze pedagogiche, né in Scienze geografiche.
Su un altro fronte, la situazione nei Conservatori di musica non è molto diversa da quando, tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, Diego Carpitella cercava di convincere i Direttori generali della Pubblica Istruzione di allora a includere la disciplina nei percorsi formativi musicali.
Da qualche tempo mi interrogo su quale sia il senso di uno studio transculturale della musica nella nostra attuale società, al di là delle legittime velleità conoscitive di un manipolo di curiosi con qualche crisi di identità. A volte sembra che quel piccolo spazio che l’etnomusicologia si è conquistata nel mondo accademico e culturale del nostro Paese sia più dovuto alla indiscussa stima e autorevolezza conquistata a suo tempo da illustri maestri come Leydi e Carpitella e da un certo qual senso “democratico” e di “correttezza politica”, che non da un vero e proprio riconoscimento di un valore culturale o scientifico.
Certamente gli etnomusicologi vi hanno messo del loro, sempre alle prese con la definizione della propria disciplina (uno potrebbe dire: “ma se non sanno nemmeno loro quello che fanno e perché!”), spesso oscillanti tra l’ideologia delle “culture subalterne” e raffinati dibattiti teorici su “emico” ed “etico”, tra il mito reazionario dell’identità culturale e le aspirazioni localistiche al riconoscimento nella “lista” Unesco.
Personalmente, ho cambiato negli anni il mio modo di insegnare, rimettendo al centro la musica, i repertori, le pratiche musicali (è ormai fuorviante chiamarle “tradizioni”) con le loro reali dinamiche di trasformazione, rispetto alle questioni teoriche e metodologiche. Non sarà proprio un “linguaggio” universale, ma certamente la musica ha una sorta di valenza transculturale intrinseca che non hanno altre forme di espressione artistica. Il punto è se avere almeno un’idea delle forme e vicende storiche della vocalità contadina, o delle armonie africane, delle improvvisazioni dei musicisti Rom o dei rapporti tra musica e trance, sia fondamentale per conoscere e capire la musica, ossia un’attività cui l’uomo, da che non è più scimmia, dedica gran parte del suo tempo. E per capire meglio Bach, Mozart, o la cosiddetta popular music.
Credo sia giunto il momento di una riflessione più ampia e condivisa su competenze transculturali e formazione, considerato anche che l’intero campo degli studi umanistici, e in particolare la stessa storia della musica, non mi pare stiano godendo di molta maggiore considerazione. Siamo tutti destinati a essere “improduttivi”?
Forse i miei pochi allievi finiranno in reparti di nicchia, tra i ristoranti etnici e i mobili etnici, o costretti a fiancheggiare qualche assessore alla cultura nell’organizzare la sagra della salsiccia, e a forza di riorganizzazioni e accorpamenti l’inutile etnomusicologia sparirà di nuovo dagli ordinamenti accademici, senza troppo danno. Ma provare a rifletterci sopra non sarebbe male. Per conto mio, mi auguro di continuare a farlo anche in altra sede.
Giorgio Adamo
Professore associato di Etnomusicologia
Università di Roma “Tor Vergata”