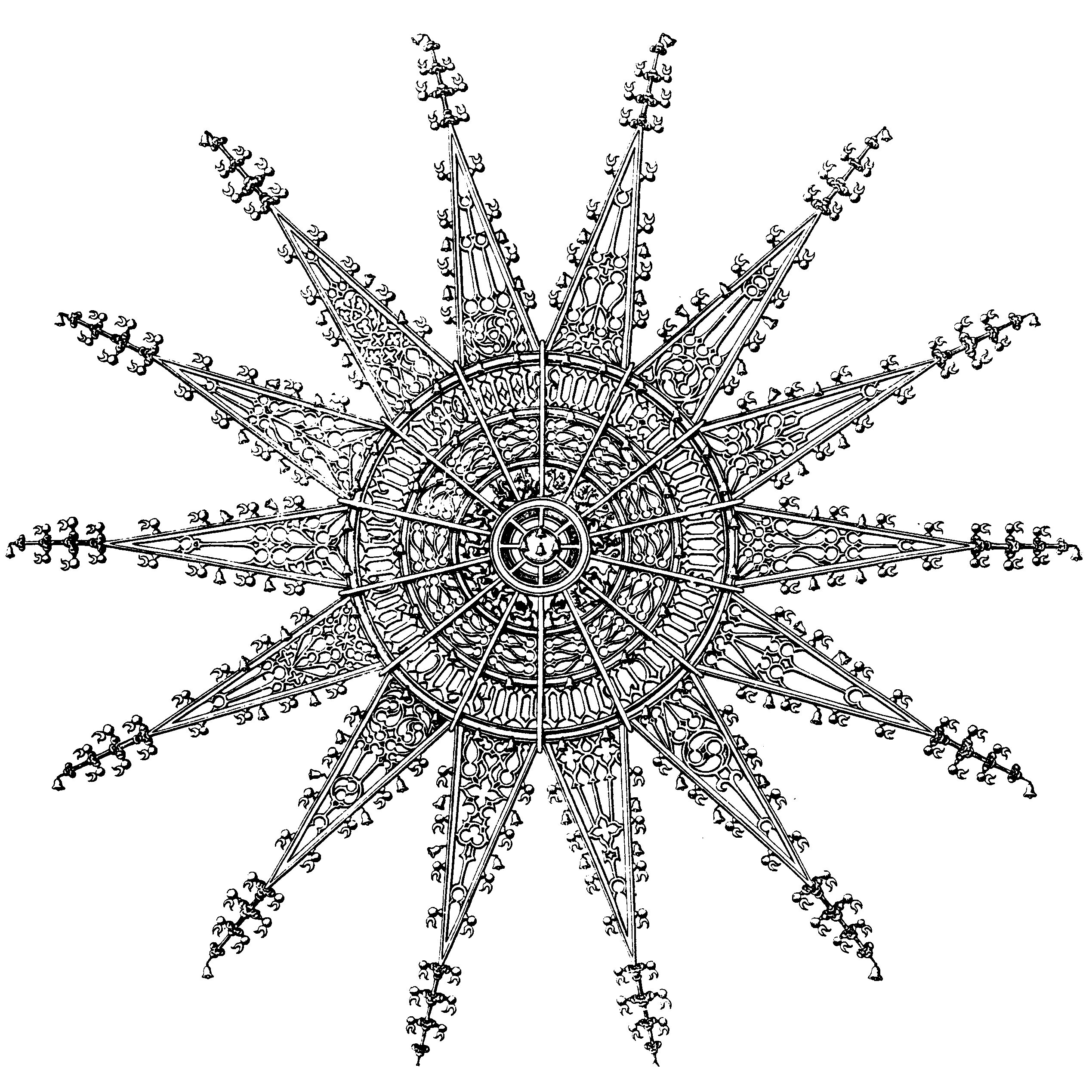Un giovane ambizioso studioso italiano delle discipline storiche deve scordarsi di nascere in un dato posto, studiarci e lavorarci: deve esporsi a idee e metodi diversi, in luoghi altri, in modo tale da poter vedere il proprio mondo di appartenenza da quella che Carlo Ginzburg ha definito ‘distanza critica’. Tuttavia, per ‘muoversi’ e avere occasioni di passare periodi di studio brevi o lunghi altrove, per poi magari non tornare più, è necessario accedere a borse di studio (fellowships) o a finanziamenti di ricerca (research grants) o anche partecipare a concorsi per posizioni di insegnamento. E qui arriva la parte complicata: da decenni ormai, è infatti diventata consuetudine che la ricerca nelle discipline umanistiche e di scienze sociali sia finanziata da bandi competitivi emessi da istituti di ricerca o università prevalentemente private e straniere. Tali bandi si ispirano a modelli impiegati nei campi scientifici e tecnologici, per di più nel contesto di un mercato del lavoro accademico divenuto globale, ma in netta contrazione anche in paesi che fino a poco tempo fa offrivano numerose e vantaggiose prospettive. Di recente tale sistema si è ulteriormente evoluto secondo logiche assimilabili al fundraising per startup che prevedono enormi sforzi iniziali di tempo e di lavoro – pensiamo per esempio a come si prepara una application per un PRIN o addirittura per un ERC – ma con un altissimo rischio d’insuccesso, che può vanificare mesi e mesi di fatiche. Inoltre, è ormai assodato che le applications per questi grandi bandi internazionali esigono un linguaggio determinato (addirittura è consigliato l’uso dell’indicativo presente anziché del condizionale) e una sequenza di argomenti predeterminata, tutto ciò corroborato da lettere di presentazione anch’esse scritte secondo un preciso codice, un’arte purtroppo poco conosciuta in Italia anche da affermati ed esperti accademici.
A questo si aggiunge un altro problema, non procedurale bensì puramente culturale: la drastica divisione avvenuta in seno alle discipline storiche fra l’Italia e il mondo anglosassone e i paesi ad esso collegati dall’altro. Laddove in Italia la ricerca tende ancora a basarsi su dati certi raccolti da indagini archivistiche eseguite con metodi filologici, altrove il ‘fare storia’ significa proporre, contraddire o ridefinire idee e concetti già espressi da altri. Tale situazione ha innescato fra i due blocchi una contrapposizione di tipo antagonistico, e spesso conflittuale, che non porta più a un benefico confronto costruttivo, bensì all’arroccamento sulle proprie posizioni, escludendosi a vicenda. Il rischio è un potenziale pericolo di trasformare la Storia da disciplina universale condivisibile e riconoscibile come forma di identità collettiva, in uno strumento nazionalistico che si fonda su fonti e bibliografie che cambiano a seconda del contesto in cui è prodotto. Uno studioso italiano all’estero ha la grande opportunità, ed ora più che mai la responsabilità, di aggiungere una maggiore libertà di pensiero fondata su metodi ‘Old Europe’, mettendo a frutto i pregi della cultura ospitante e di quella d’appartenenza. Ma per farlo deve imparare il linguaggio e le tecniche delle applications, che all’estero, già da molto tempo, si insegnano fin dalle scuole elementari.
Francesco Benelli
Professore associato di Storia dell’Architettura
Dipartimento delle Arti – Università di Bologna