Quando Hector Berlioz pubblicò Le Chef d’orchestre come appendice alla seconda edizione del Grande traité d’instrumentation et d’orchestration moderne (1856) la direzione d’orchestra intesa come disciplina andava perfezionandosi da almeno un ventennio.
Ben prima di Berlioz, François Habeneck, leggendario direttore e fondatore dell’Orchestra della Société de Concerts de Paris, aveva cambiato il verso cui tendeva la professionalità direttoriale: da coordinatore delle attività musicali a interprete della partitura.
La venerazione di cui fu oggetto, persino da Wagner, rappresentò una svolta: in un’epoca in cui le orchestre prevalentemente leggevano a prima vista, Habeneck provò per ben tre anni la Nona Sinfonia di Beethoven, non perché dovesse ‘imparare’ a dirigerla, ma perché dovette avvertire la responsabilità di guidare verso la perfezione esecutiva i musicisti, in un momento in cui si stava edificando il repertorio attraverso la musica di Beethoven.
Nel mondo di oggi, che scorre velocissimo tra i pixel di un’immagine su Instagram, quanto rimane del tempo del quale un concerto avrebbe bisogno per sedimentare negli interpreti e nel pubblico?
Come ha recentemente scritto Alex Ross sul «New Yorker» del 2 aprile di quest’anno (Conductors Had One Job: Now They Have Three or Four): «Once upon a time, young conductors got their start with regional ensembles and worked their way up to the supposed big leagues» e ancora «[…] in their early years these prodigious neophytes tended to devote themselves single-mindedly to their ensembles. They built something substantial before moving on».
Di fronte a una qualità crescente delle orchestre, che potrebbero talvolta benissimo cavarsela da sole, la figura del direttore tende a confondersi con la propria immagine. Per Ross, sempre più giovani uomini – quasi mai donne, ma questo richiederà un’altra ‘goccia’ – volano da un’orchestra a un’altra, mancando del tempo materiale per un lavoro di analisi e interpretazione della partitura, per prove approfondite e per costruire un rapporto fiduciario con gli orchestrali e con gli spettatori. Il divismo e l’attenzione per l’aspetto esteriore producono un indotto enorme in termini di incasso e visibilità, e decretano un sold out di pubblico che dell’esecuzione ricorderà la passione del direttore, la gestualità ostentata, invece che l’interpretazione di un dettaglio nascosto lì dove nessuno aveva saputo trovarlo, o l’intenso pedale di dominante del drammatico finale di uno sviluppo. Così, la musica da cultura diventa intrattenimento: sensazionale, spettacolare, glamour, esperienza che non ci riguarda più da vicino ma che ammiriamo con compiacimento, salvo poi rimpiangere i “grandi interpreti” del bel tempo passato.
Claudia Patanè
Dottoranda in Musica e Spettacolo,
Università di Roma ‘Tor Vergata’
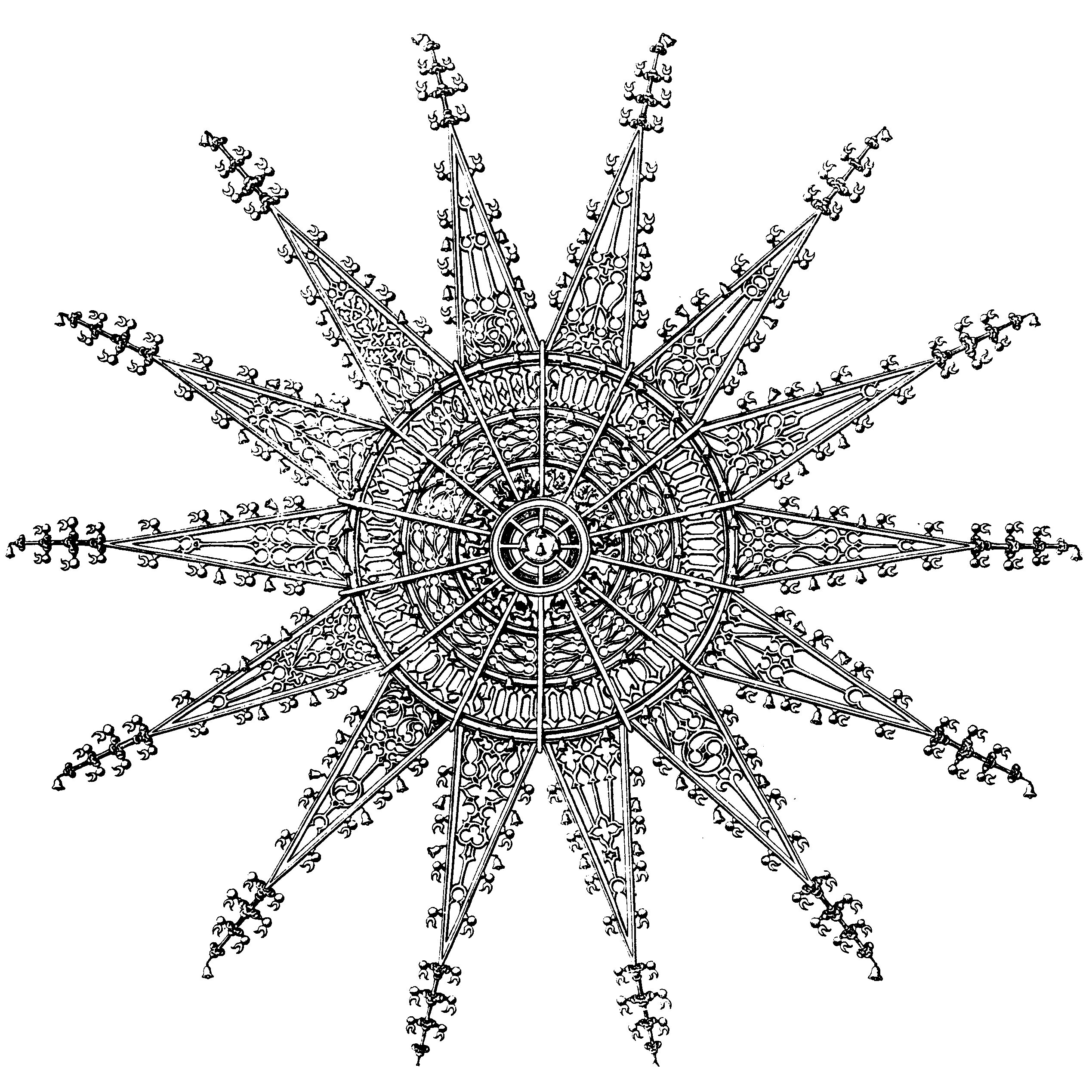
So true!