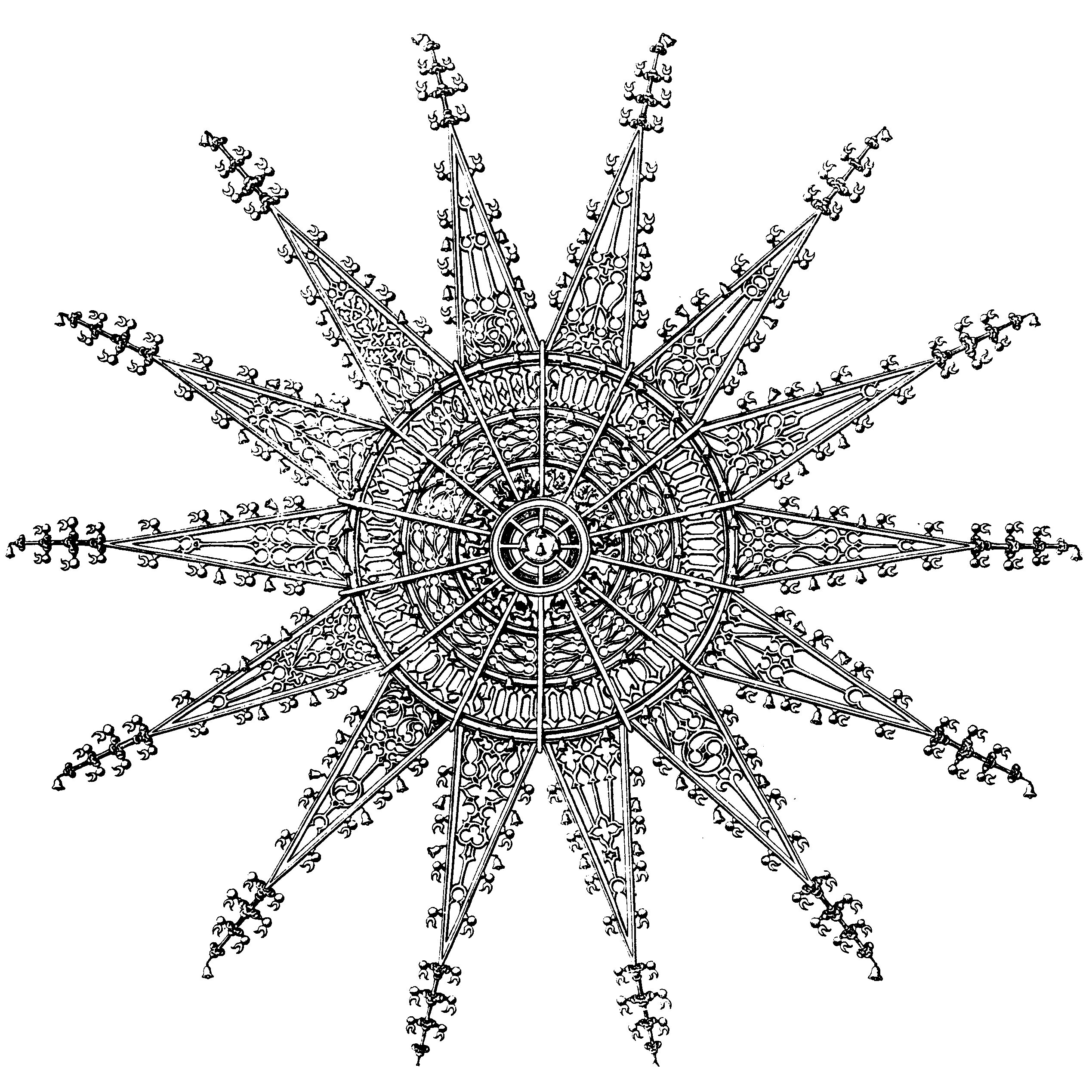Hans Heinrich Eggebrecht (Friburgo in Brisgovia)
Oggetto del presente saggio è il testo intitolato Ein wunderbares morgenländisches Märchen von einem nackten Heiligen (La meravigliosa favola orientale di un santo ignudo). Si trova nelle Phantasien über die Kunst für Freunde der Kunst (Fantasie sull’arte per amici dell’arte) che, pubblicate da Ludwig Tieck nel 1799, raccolgono scritti perlopiù di mano di Wilhelm Heinrich Wackenroder, l’amico di Tieck scomparso l’anno prima. Si discute se il testo della favola sia stato scritto da Tieck o da Wackenroder; tuttavia non entrerò nel merito della questione: ci sono ragioni consistenti per ritenere che l’autore sia Wackenroder, e a questa ipotesi mi attengo.
Il testo non è una fiaba d’altri tempi, bensì una fiaba artistica. L’irreale, il simbolico, il meraviglioso che rimanda ad un’essenza, tutti questi aspetti della fiaba popolare sono qui “costruiti”, poetati, stilizzati in chiave poetica. E questa stilizzazione fiabesca pare essere stata tessuta consapevolmente in modo tale che l’enunciazione verbale fugge nell’indeterminato, là dove domina l’irreale in inesauribile molteplicità, al di là di ogni ratio e di ogni logica. Ha qui un certo peso un fondamentale tono romantico, legato all’epoca storica: l’oriente come “patria del meraviglioso”, il chiaro di luna, il suono del corno, la negazione della realtà presente e soprattutto la musica come potenza redentrice. Ma si tratta di sganciare questa fiaba dalla prospettiva specificamente romantica, e di trasferirla in un orizzonte non vincolato al tempo storico: procedure che riguardano anche le interpretazioni estremamente sfaccettate e divergenti della fiaba offerte dagli storici della letteratura. “La fiaba conta tra i testi di Wackenroder più frequentemente analizzati”, scrive Silvio Vietta nell’edizione storico-critica (curata insieme a Richard Littlejohns) delle opere complete e dell’epistolario di Wackenroder (I, Heidelberg, Winter, 1991, p. 390). Il curatore menziona alcune tra le varie interpretazioni date al motivo qui centrale della ruota del tempo: simbolo del nichilismo e dell’angoscia suscitata dal tempo; simbolo dell’immagine meccanicistica del mondo tipica dell’illuminismo; visione del vuoto girare del mondo moderno del lavoro e della prigionia nel circolo produzione/consumo; simbolo della monotonia della condizione umana in genere.
Ciò che in rapporto alla fiaba deve essere unicamente esaminato qui, nel quadro di un saggio dedicato alla musica come tempo, è una domanda affatto semplice e – per quanto ne so – sinora mai posta: in che misura, qui, la musica realizza la liberazione dal tempo?5
Anzitutto leggeremo la fiaba per intero. Un secondo passo consisterà nel riflettere sulla fiaba tenendo presente quella domanda, prima di tentare – e sarà il terzo passo – di darvi una risposta.
L’oriente è la patria di tutte le meraviglie: nell’antichità e nell’infanzia delle idee dei popoli orientali si trovano anche i più strani misteri ed enigmi che ancora e sempre si presentano insoluti all’intelletto, il quale, pure, ha motivo di ritenersi abbastanza scaltro. Abitano dunque spesso in quei deserti degli esseri strani, che noi chiameremmo pazzi, ma che là sono venerati come esseri soprannaturali. Lo spirito orientale considera questi santi, che vivono ignudi, come bizzarri ricettacoli di un genio superiore, che dal regno delle stelle si smarrì in una forma umana, e che ora non sa comportarsi secondo la maniera degli uomini. Anche nel mondo, a dire il vero, tutte le cose appaiono in una maniera o nell’altra a seconda di come le consideriamo; l’intelletto umano è un elisir meraviglioso, pel contatto del quale tutto ciò che esiste viene trasformato a nostro piacere.
Abitava dunque uno di questi santi ignudi in una caverna solitaria, tra rocce, e lì vicino passava un ruscello. Nessuno poteva dire come egli fosse arrivato fin là: da alcuni anni la sua presenza era stata notata, una carovana lo aveva scoperto per prima; e da allora andavano spesso pellegrinaggi alla sua dimora solitaria.
Questo bizzarro essere non aveva, notte e giorno, mai pace nella sua dimora; sempre gli pareva d’aver nelle orecchie la ruota del tempo che senza posa girava, rombando. Egli non poteva far nulla a causa di questo frastuono, niente poteva intraprendere; la violenta angoscia, che lo affaticava in un lavoro senza riposo, gli impediva di vedere o di udire qualunque cosa, come se la terribile ruota girasse e rigirasse nell’aria con un gran fragore, con un potente rombo di vento in tempesta, fino ad arrivare alle stelle e più sù. Come una cascata di mille e mille mugghianti ruscelli che cadono dal cielo, eternamente, senza un attimo di riposo, senza la pace di un secondo, si riversa giù, così quest’urlo risuonava nelle sue orecchie, e tutti i sensi ne erano avvinti e la sua angosciata fatica sempre più era presa e trascinata via nel vortice di quella selvaggia impressione, sempre più mostruosi si scatenavano l’un sopra l’altro i suoni uniformi. Egli non poteva aver pace, e notte e giorno lo si vedeva affaticarsi nel movimento più sforzato e violento, come un uomo, appunto, che si dia pena per far girare un’immensa ruota. Dai suoi discorsi, rotti e selvaggi, si capiva che si sentiva trascinato da quella ruota, e che voleva venire in aiuto con tutto lo sforzo del suo corpo a quel tonante e fischiante girare, affinché il tempo non corresse il pericolo di rimanere un sol momento fermo. Se qualcuno gli domandava che cosa facesse, egli gridava come in delirio queste parole: “Infelici, non sentite la scrosciante ruota del tempo?”. E rigirava e lavorava ancor più impetuosamente, così che il sudore gli scorreva sino a terra, e metteva con gesti stravolti la mano sul cuore, quasi volesse sentire se la grande ruota fosse ancora in movimento, nel suo eterno andare. Si arrabbiava quando vedeva che i viandanti, venuti in pellegrinaggio da lui, se ne stavano tutti tranquilli a guardarlo, oppure gironzolavano di qua e di là e chiacchieravano tra di loro. Tremava di collera e mostrava loro il girare inesausto dell’eterna ruota, la continua corsa uniforme e ritmica del tempo: digrignava i denti perché nulla essi sentivano e vedevano di quel turbinio nel quale loro stessi erano avviluppati e trascinati; e li scagliava lontano se, mentre durava la sua furia, venivano troppo vicino a lui. Per non correr pericolo, dovevano anch’essi imitarlo con vivacità in quel suo movimento che tanto lo affaticava.
Ma il suo furore diventava ancor più selvaggio e pericoloso se avveniva che nelle vicinanze si compiesse qualche lavoro manuale o se qualcuno, che non lo conosceva, si mettesse, vicino alla sua caverna, a raccogliere erbe o a tagliar legna. Allora scoppiava selvaggiamente a ridere pel fatto che in mezzo al terribile rotolare del tempo ci fosse ancora qualcuno che poteva pensare a quelle piccole occupazioni terrestri. Come una tigre, con un unico salto, usciva fuori dalla grotta, e se poteva acciuffare l’infelice, con un solo colpo lo stendeva morto a terra. Poi ritornava svelto alla sua grotta, e ancor più impetuosamente di prima si metteva a girare la ruota del tempo; ma continuava a infuriare per un pezzo, e con parole monche domandava come fosse possibile agli uomini poter far qualcosa di diverso da quello che egli faceva, e soprattutto lavori insensibili al ritmo del tempo.
Non era capace di stendere il braccio verso un oggetto qualunque o di afferrare qualcosa con la mano; non poteva fare un passo, come gli altri uomini. Un tremito angoscioso attraversava tutti i suoi nervi, se anche una sola volta avesse cercato d’interrompere il vorticoso movimento che gli dava le vertigini. Solo di quando in quando, nelle belle notti, quando la luna arrivava all’improvviso davanti all’apertura della sua buia grotta, d’un colpo si fermava, cadeva a terra, si rivoltava gridando per la disperazione; e si metteva anche a piangere amaramente come un bimbo perché il rombare della potente ruota del tempo non gli lasciava la pace necessaria a poter fare qualche cosa di diverso sulla terra, a lavorare, a operare e creare. Allora sentiva una struggente nostalgia di cose belle e sconosciute; e tentava di alzarsi sù, di dare alle mani e ai piedi un movimento dolce e tranquillo, ma invano! Cercava qualche cosa di sicuro e che prima di allora non aveva conosciuto, alla quale afferrarsi e tenersi attaccato: voleva salvarsi, ma invano! Il suo pianto e la sua disperazione arrivavano all’estremo; con alti urli saltava sù da terra, e di nuovo si attaccava a girare la potente, rombante ruota del tempo. Così durò parecchi anni, giorno e notte.
Ma una volta che era una notte d’estate meravigliosa e chiara di luna, ecco che il santo giaceva di nuovo a terra, nella sua grotta, piangente e con le braccia brancolanti. La notte era incantevole: nel firmamento di un azzurro cupo brillavano gli astri come fregi d’oro su uno scudo protettore, immensamente largo, e la luna irraggiava dalle chiare gote della sua faccia una dolce luce, nella quale si bagnava la terra verde. Gli alberi stavano nella luce incantata come nuvole ondeggianti sui loro tronchi, e le abitazioni degli uomini erano trasformate in forme scure di rocce e in palazzi dalle forme fluttuanti e fantastiche. Gli uomini, non più accecati dallo splendore del sole, si attaccavano con gli sguardi al firmamento, e le loro anime si specchiavano belle nel lucore celeste della notte lunare.
Due innamorati, che volevano abbandonarsi completamente alle meraviglie della solitudine notturna, su una barchetta leggera risalivano in quella notte il fiume che scorre accanto alla grotta rocciosa del santo. Il penetrante raggio lunare aveva illuminato e svegliato nei due innamorati le più intime e oscure profondità delle loro anime, i loro sentimenti più lievi si scioglievano e fluttuavano come un unico fiume senza rive. Dalla barca, una musica eterea saliva ondeggiando nell’ampiezza del cielo: dolci corni o non so quali altri incantevoli strumenti suscitavano un mondo nuotante di suoni, e nelle note, che ora salivano ora scendevano a ondate, si poteva distinguere il seguente canto:
Dolci brividi accarezzano
l’acqua e i campi addormentati,
della luna i raggi formano
letto ai sensi inebriati.
Ah, come attira l’onda, e sussurra,
e il cielo specchiasi nell’acqua azzurra.
Astri sù nel cielo brillano,
astri brillan giù nei flutti:
se non fosse Amore ad accenderli,
spenti resterebber tutti;
e nel respiro che il ciel disserra
ridono il cielo, l’acqua e la terra.
Su ogni fior la luna stendesi,
dormon già tutte le palme;
dell’Amor suona la musica
nelle selve austere e calme:
dal tenue suono la palma e il fiore
sognando apprendono il dolce Amore.
Appena risuonarono la musica e il canto, la rombante ruota sparì di mano al santo ignudo. Erano quelle le prime note musicali che cadevano nel deserto, e subito lo sconosciuto desiderio fu quietato, l’incanto disciolto, il genio, che si era smarrito, fu liberato dal suo involucro. La forma umana del santo era scomparsa, un’immagine spirituale bella come un angelo, intessuta di vapore leggero, stava sospesa fuori della grotta, e stendeva, piena di nostalgia, le braccia snelle al cielo, e s’innalzava secondo le note della musica in un movimento di danza, dalla terra verso l’alto. In alto, sempre più in alto, si librava nell’aria la lucente forma aerea, portata sù dalle note, che dolcemente si gonfiavano, dei corni e del canto. Con gioia celeste lo spirito danzava qua e là, e di nuovo là e qua, sulle bianche nubi che nuotavano negli spazi dell’aria; sempre più in alto egli salì con piedi danzanti nel cielo e infine s’inoltrò con volute intrecciate tra le stelle: allora risuonarono tutte le stelle e mandarono un celeste tintinnio, chiaro come un raggio negli spazi celesti, fino a che il genio si perdé nel firmamento infinito.
Carovane in cammino guardavano stupite la meravigliosa apparizione notturna e gl’innamorati credettero di vedere il genio dell’amore e della musica.6
Come un genio, il santo proviene “dal regno delle stelle”. Per essersi “smarrito” in una figura umana gli tocca sperimentare l’esistenza del tempo; egli lo sperimenta come ruota del tempo, e nella sua nudità è esposto senza difese a tale esperienza. Egli soltanto, nel suo isolamento, è consapevole di cosa sia il tempo: quest’ultimo lo domina in modo tale che egli non solo ode incessantemente il “rombare della potente ruota del tempo”, ma deve egli stesso girarla con costrizione ineluttabile e senza posa e con sforzo estremo, “affinché il tempo non corra il pericolo di rimanere un sol momento fermo”. Anche gli altri uomini, che onorano il solitario per la sua santità e si recano in pellegrinaggio da lui, sono “avviluppati e trascinati” nel vortice del tempo, solo che non lo sentono, e non se ne accorgono. Essi sono affaccendati in occupazioni consuete; tocca al santo rendersene conto, con somma pena; per questo egli viene preso dalla pazzia e spinto al delitto.
“Solo di quando in quando”, allorché nelle belle notti la luna entra nella sua grotta, c’è un momento di sosta. Allora il santo piange, perché il sibilo della ruota del tempo lo assorbe completamente e “non gli lascia la pace necessaria a poter fare qualche cosa di diverso sulla terra, a lavorare, a operare e creare. Allora sente una struggente nostalgia di cose belle e sconosciute”. Ma presto la ruota lo afferra di nuovo, egli balza in piedi “e di nuovo si attacca a girare la potente, rombante ruota del tempo”, per anni, giorno e notte.
Ma poi, ecco la liberazione. In una “notte d’estate meravigliosa e chiara di luna” due amanti su un’imbarcazione risalgono il corso del fiume che scorre tra le rocce presso la grotta del santo. “Dalla barca una musica eterea sale ondeggiando nell’ampiezza del cielo: dolci corni o non so quali altri incantevoli strumenti suscitano un mondo nuotante di suoni, e nelle note, che ora salgono ora scendono a ondate, si può distinguere il seguente canto”, un canto (su un poemetto in tre strofe) dedicato all’amore, in cui il suono – nel chiaro di luna e nello splendore delle stelle – viene cantato in cosmica ebbrezza come suono “dell’Amore”: “Dal tenue suono la palma e il fiore | sognando apprendono il dolce Amore”.
Ed ecco il passo decisivo dell’intera fiaba: “Appena risuona la musica e il canto, la rombante ruota sparisce di mano al santo ignudo. Sono le prime note musicali che cadono nel deserto, e subito lo sconosciuto desiderio è quietato, l’incanto disciolto, il genio, che si è smarrito, viene liberato dal suo involucro”. La figura del santo è scomparsa; “un’immagine spirituale bella come un angelo … s’innalza secondo le note della musica in un movimento di danza, dalla terra verso l’alto”, sino alle stelle. E “allora risuonano tutte le stelle e mandano un celeste tintinnio, chiaro come un raggio negli spazi celesti, fino a che il genio si perde nel firmamento infinito”.
“Carovane in cammino guardano stupite la meravigliosa apparizione notturna e gl’innamorati credono di vedere il genio dell’amore e della musica.”
In questa fiaba vien detto con chiarezza che è la musica a liberare dal tempo il santo ignudo, cioè colui che avverte il tempo come maledizione dell’esistenza terrena: “Appena risuonarono la musica e il canto, la rombante ruota sparì di mano al santo ignudo”. Ma prima di chiederci come possa la musica realizzare questa liberazione, è necessario riflettere in via preliminare su due questioni.
Anzitutto: la liberazione dalla ruota del tempo non avviene qui solo grazie alla musica, ma in virtù della combinazione di musica e amore. “E gl’innamorati credettero di vedere il genio dell’amore e della musica”. Quanto al canto, che nell’imbarcazione dei due innamorati poteva essere percepito come musica, si tratta del suono “dell’Amore”. Ho sempre avuto l’impressione che questi versi sull’amore abbiano avuto una genesi autonoma e siano stati inseriti a bella posta nella fiaba. Di fatto, stando alle analisi filologiche (cfr. Vietta, pp. 370 sg. e 390), è probabile che essi non siano di Wackenroder, bensì di Tieck. Nella fiaba l’amore è incluso nella “musica eterea” come la suprema, celeste, cosmica forma di vita: forse allo stesso modo dell’ambiente romantico del “lucore celeste della notte lunare” e della “struggente nostalgia di cose belle e sconosciute”, che forma qui una cornice. A questo proposito si dovrebbero studiare più da vicino, nel romanticismo, le relazioni tra il topos dell’amore e i topoi ‘musica’ e ‘tempo’. Del tutto chiaro è però che in Wackenroder la musica – quale che sia il topos cui si unisce – procura la liberazione. Il santo ignudo sperimenta di fatto la musica, allorché essa è presente come entità effettivamente percepibile coi sensi e lo pervade. In questa immediatezza, però, l’amore non è realmente presente; esso può solo essere descritto in immagine. Nella fiaba viene nominato ed evocato nell’immagine di una coppia di innamorati su un’imbarcazione che risale la corrente. Qui esso non libera da sé e di per sé, ma al modo che viene percepito come musica, cioè come testo di una canzone.
In secondo luogo: che ne è degli altri, di quelli che non sono un santo ignudo? Vengono liberati anch’essi? Non viene forse liberato solo colui che, in quanto “genio”, ha conosciuto il tempo come maledizione della ruota? È forse qui in gioco una prospettiva elitaria, nel senso che verrà liberato solo l’eletto che, nell’isolamento romanticamente idealizzato, sia consapevole del dolore, mentre tutti gli altri soggiaceranno alla ruota, senza saperlo? Questa domanda riconosce e tiene presente la fiaba, senza che se ne debba dare qui un’esplicazione dettagliata. Essa tiene conto del potenziale di liberazione che vale per tutti gli uomini: “Carovane in cammino guardavano stupite la meravigliosa apparizione notturna…”.
Si può, e anzi si dovrebbe concepire la fiaba in modo tale che il santo ignudo funga da rappresentante dell’umanità intera. Questo però significa in pari tempo che – proprio come il santo “dal regno delle stelle si smarrì in una forma umana” – tutti gli uomini sono esseri smarriti, e che l’altro mondo, il mondo delle stelle, in cui la musica può redimerli, è il mondo autentico. Ma se ci chiediamo in che modo la musica possa realizzare la liberazione dalla ruota del tempo, sarà necessario tentare di prescindere da tutti questi problemi – romanticismo, topos dell’amore, isolamento o funzione vicaria dell’eletto – e collocare per così dire la fiaba in una dimensione atemporale. Si tratta qui di distinguere tra la risposta data dalla fiaba e la risposta che la oltrepassa.
La fiaba si muove tra terra e cielo: “lo spirito orientale” venera i santi ignudi come “esseri soprannaturali”, “come bizzarri ricettacoli di un genio superiore, che dal regno delle stelle si sia smarrito in una forma umana, e che ora non sa comportarsi secondo la maniera degli uomini”. Il santo proviene anch’egli dall’aldilà rispetto al mondo terreno degli uomini. Anche la musica proviene da un aldilà; è sì prodotta con mezzi terreni nell’imbarcazione degli innamorati, che naviga sotto il cielo notturno stellato, ma è di essenza “eterea”. La musica libera dal tempo, inteso come incarnazione stessa della prigionia in terra, allorché innalza l’ascoltatore sino all’aldilà dal quale risuona. L’immagine spirituale bella come un angelo in cui la figura del santo si era trasformata fluttuò danzando “nel cielo e infine s’inoltrò con volute intrecciate tra le stelle: allora risuonarono tutte le stelle e mandarono un celeste tintinnio, chiaro come un raggio negli spazi celesti, fino a che il genio si perdé nel firmamento infinito”.
Dietro all’immagine – la cosa mi sembra indiscutibile – sta il topos, tramandato dall’antichità e poi dal medioevo, dell’armonia delle sfere, del movimento degli astri che vibra come musica celeste. Quest’ultima si riteneva rientrasse nella musica mundana (’armonía kósmou), nell’ordinamento del macrocosmo basato su proporzioni numeriche, che nella musica effettivamente risonante, nella musica sonora prodotta con mezzi terreni, rispecchia l’atemporalità dell’ente e la trasmette all’anima umana nel senso di una presentazione di ciò che sta aldilà, del divino, dell’infinito ed eterno.
Musica mundana e musica delle sfere, nella fiaba, non fungono però – è ovvio – da elementi storicistici evocati per spiegare qualcosa, bensì da perifrasi figurative dell’inspiegabile, del potere della musica di liberare dalla finitezza, che per Wackenroder rimane in ultima analisi, anche in tutti gli altri suoi scritti, un qualcosa vissuto come inspiegabile, il miracolo di un altro mondo, che proviene dall’aldilà e dell’aldilà apre le porte. “Venite, suoni”, è la conclusione della riflessione di Wackenroder su Das eigentümliche innere Wesen der Tonkunst (La peculiare essenza della musica), “…avviluppatemi con i vostri raggi milliformi nelle vostre nuvole splendenti, e sollevatemi sù, nel vecchio abbraccio del cielo che tutto ama”. E l’uomo romantico – sino ai nostri giorni – può essere incline ad appagarsi di un così bel simbolismo.
Tuttavia all’interrogazione circa il potere liberatorio della musica mi sembra si possa dar risposta concreta in un solo modo: se cioè al tempo concreto che tiene prigioniero l’uomo come ruota del tempo si contrappone un altro tempo concreto, che opera questa liberazione. La liberazione da un tempo concreto è possibile solo mediante un altro tempo, altrettanto concreto.7
Ma qui giova ricordare, in pillole, il pezzo breve precedente, Musica come tempo. Questo altro tempo rappresenta il tempo musicale, che in quanto tale non è inglobato e imprigionato nel tempo prefissato, nel senso che gli appartiene, lo utilizza e lo sfrutta, bensì fonda, pone e crea il tempo. In tal modo la musica, rispetto alla coscienza del tempo in quanto ruota, media una coscienza completamente diversa, la coscienza dell’autoporsi del tempo. Quel che la musica come tempo può offrire alla comprensione intellettuale, nella sua sostanza, è, oltrepassando anche il mondo estetico, l’unica possibilità di liberazione dal tempo che l’uomo abbia in genere. Il tempo passivo viene depotenziato dal tempo attivo. Il fermarsi del tempo, l’eternità e l’infinità sono il fermarsi della ruota, la neutralizzazione del dolore provocato dalla sua rotazione. Per il tempo attivo l’immagine della ruota ha perduto la propria validità.
Il tempo è il fattore numerico nel movimento. La filosofia del tempo in Aristotele
Aristotele offre un’analisi del tempo nel libro IV della Fisica. Alla base delle pagine che seguono sta l’edizione tedesca, con testo greco a fronte, curata da Hans Günter Zekl: Aristoteles’ Physik: Vorlesung über Natur, I: Bücher I (A) – IV (D), Hamburg, Meiner, 1987.
Aristotele inizia le sue delucidazioni sul tempo (hrónos) con la domanda “se esso appartenga all’ente o al non-ente”, cioè se esso sia nella realtà effettuale oppure no. Ma dove è, se è un ente? Ciò ch’è trascorso non è più, ciò che deve venire non è ancora. Ambedue dunque non hanno alcun è. Anche per questo essi non lo hanno, perché non sono mai la stessa cosa, ma sempre diversi.
Passato e futuro sono parti di un intero diviso dall’attimo (Jetzt). Neppure l’attimo, però, ha un è, dal momento che non solo è divisibile all’infinito, ma è anch’esso sempre un diverso.
Il tempo, nel suo essere, è legato al movimento, a mutazione e cambiamento. Senza movimento il tempo non può essere, e ogni cambiamento, e ogni mutarsi, sono nel tempo. Ma il tempo non può essere equiparato al movimento. Infatti, ad esempio, ‘movimento’ significa ‘mutarsi’; “il tempo, per contro, è allo stesso modo tanto ovunque che in tutte le cose”. Oppure, altro esempio, una mutazione può decorrere più rapidamente o più lentamente; ma il tempo non lo può.
E dunque:
Se l’impressione che il tempo non scorra si dà a noi allorché [ad esempio durante un sonno profondo] noi non possiamo cogliere in modo determinato nessuna mutazione, e la coscienza (psuhé) pare invece rimanere in un unico (attimo) immediato, e d’altro canto allorché noi percepiamo (mutazione) e la determiniamo ponendo dei confini e diciamo allora che è trascorso del tempo, allora è palese che senza movimento e senza mutazione il tempo non è. Balza evidente pertanto che il tempo non è uguale al movimento, e però neppure è senza movimento.
Riflessione – Tutto ciò vale anche per la musica: il tempo è legato al movimento, ma non può esservi equiparato. Nel suono, tutto è movimento: il processo di produzione, la vibrazione dell’aria, la sua diffusione nello spazio, l’essere accolta nell’orecchio. Ma il movimento che l’orecchio percepisce come suono, al pari del movimento in genere, non può essere equiparato al tempo, proprio come il movimento. Vista così, la musica non è affatto un’”arte temporale”, un’arte che consiste di tempo, bensì arte del movimento, arte che consiste di movimento. Il tempo, come tale, non c’è; c’è solo nel movimento.
È difficile pensare una cosa del genere, poiché il pensiero della quotidianità parla sempre di tempo, quando intende il movimento, e viceversa. Ad esempio: “il tempo va all’indietro”, se è il movimento ad andare all’indietro – il tempo non può andare all’indietro. Oppure: il movimento muta, se “il tempo muta” – il tempo non può mutare.
Già qui spunta in Aristotele un altro pensiero, che mi limiterò per ora a sottolineare di sfuggita. Esso riguarda la coscienza (psuhé): se la coscienza non coglie alcun movimento (mutazione), ma pare rimanere in un unico attimo (ad esempio nel sonno profondo), sorge l’impressione che il tempo non scorra. Ciò significa: la coscienza è il presupposto (o l’impressione) del tempo.
“Ma ora, cos’è il tempo nel decorso del movimento?”, si chiede Aristotele più avanti. Non è movimento (estensione, decorso) nudo e crudo, bensì la grandezza del movimento, che viene limitata mediante un attimo oppure due attimi (iniziale e finale). Il movimento si muove da qualcosa verso qualcos’altro, da un prima a un dopo, e nel mezzo si situa l’attimo. Solo mediante una suddivisione ovvero una delimitazione di attimi è possibile cogliere il movimento come grandezza. Ma come l’attimo non ha modalità d’essere, poiché è costantemente diverso in luoghi diversi, allo stesso modo la grandezza del movimento delimitata dall’attimo non ha alcuna modalità d’essere, poiché anch’essa non è mai la stessa.
Ma sotto altro profilo l’attimo è sempre lo stesso, cioè sotto il profilo della sua funzione di delimitare, che in quanto funzione è in ogni punto temporale la medesima.
Il tempo è la grandezza dell’estensione, che può essere misurata con l’aiuto dell’attimo. La misurazione ha luogo mediante il numero. Il tempo dunque non è né il movimento né l’attimo che delimita il movimento; ambedue sono irrinunciabili per il tempo, ma nessuno dei due è un ente. Il tempo è il decorso del movimento delimitato dagli attimi e calcolato mediante il numero: l’”unità di misura” del movimento delimitato da un attimo. Nel numero infinitamente grande di elementi differenti presenti in ciò ch’è simultaneo e nel decorso infinito del movimento il numero è un ente, tanto più che il molto e il diverso possono avere la stessa unità di misura.
“Tempo è numero” (hrónos aruthnós éstín), nel senso che il tempo è “il fattore numerico nel movimento”.
Riflessione – Partendo da qui si può pensare quanto segue in rapporto alla musica: anche nella musica il tempo è il movimento dell’intero, e dei suoi componenti, delimitato da un attimo, sino al più piccolo dettaglio. E si potrebbe pensare che anche nella musica il movimento delimitato sia determinato, in rapporto al tempo, dalla sua calcolabilità. Così anche in rapporto alla musica il tempo sarebbe “il fattore numerico nel movimento”. Ciò significa che se si vuole cogliere il tempo nella musica, si deve calcolare. E si può ben dire che tutto ciò, nella storia della musica, ha una parte importante. Nella musica misurata, elevata a sistema nella musica modale e mensurale del medioevo e dominante nella musica a regime di battuta del sistema tonale moderno, il tempo è largamente concepito come se si trattasse del “fattore numerico nel movimento”.
Ma ora chiediamoci:
- ascoltando musica, noi calcoliamo?
- due suoni di egual valore di durata, anche nella musica mensurale e in quella soggetta a battuta e metronomizzata, non hanno mai lo stesso tempo;
- nella musica, tanto più in quella polifonica (e quanto più essa diviene artificiosa), la ricchezza degli attimi e dei decorsi di moto misurabili mediante gli attimi in quanto numeri non può in genere essere còlta.
Tuttavia, in Aristotele – vorrei qui sottolinearlo – il tempo non viene consumato come movimento esistito in precedenza, poiché il tempo inerisce sì al movimento, ma non è uguale ad esso. Il tempo vien posto da Aristotele mediante l’attimo, che nel movimento fonda lo spazio temporale afferrabile come numero, per cui il soggetto (la psychè) in quanto coscienza numerativa è il fondatore – e la fondazione tramite il soggetto è valida sino ad oggi.
Però mi sembra che questa fondazione del tempo in Aristotele non sia altro che quel che ho chiamato tempo oggettivo: il ‘tempo degli orologi’. Il tempo è un ente, dice Aristotele (e io lo ripeto qui), perché il numero infinitamente grande di elementi differenti presenti in ciò ch’è simultaneo ed il decorso infinito del movimento possono avere la stessa unità di misura. E questo è l’orologio. Nel suo mondo greco (precristiano) Aristotele non conosce il soggetto nel senso del tempo vissuto e concepito. Tutto questo è entrato nella riflessione filosofica seicento anni dopo, con Agostino, anche se poi venne di nuovo dimenticato per lungo tempo. Aristotele non conosce, e non può né conoscere né pensare, la fondazione del tempo, che è un ente solo mediante il soggetto.
Alcuni aspetti della filosofia aristotelica del tempo dovranno ora chiarificare e sviluppare ulteriormente quanto si è sin qui riferito e meditato. Questi aspetti riguardano la quiete, l’eterno, la coscienza, e ancora una volta il tempo degli orologi.
- La quiete – La quiete, in cui nessun movimento ha luogo, appartiene secondo Aristotele anch’essa al tempo, in quanto è il movimento che passa alla quiete. “Non ogni immobile infatti è in quiete, ma solo quell’immobile che è predisposto per natura al movimento, ma che presentemente non ha accesso al movimento”. La quiete è il non-movimento di qualcosa che potrebbe muoversi. “Essere-nel-tempo significa esser misurato dal tempo, ma il tempo è misura di movimento e di quiete”. È del tutto chiaro che tali riflessioni interessano – a grandi linee – anche la pausa in musica: essa (secondo Aristotele) è la misura, calcolabile come tempo, della quiete di ciò che sonoramente si muove. Queste nozioni vanno alla radice del problema circa la pausa e il silenzio in genere in musica, con una radicalità che non vale solo per le definizioni lessicografiche di ‘pausa’, ma anche per la filosofia musicale della pausa. In esse è compreso il fatto che il genere di movimento che trova quiete nella pausa determina il genere di pausa.
- L’eterno – “L’eterno non è nel tempo”. Esso non ha delimitazioni prodotte dagli attimi, e pertanto “la durata del suo essere non è misurata mediante il tempo”. Poiché ciò che sempre sussiste, l’ente eterno, non è nel tempo, “nulla gli si fa incontro mediante il tempo”. Esso non ha le proprietà di essere movimento con istanti, di essere transitorio e di poter sorgere, di essere ora sì e ora no. Aristotele fa un esempio tratto dalla matematica, più esattamente dalla geometria: la diagonale di un quadrato non è misurabile in unità uguali rispetto al lato. Questo è qualcosa che sussiste sempre, e perciò non è nel tempo. Il contrario dell’ente eterno è il non-ente (eterno). Ad esempio, un quadrato in cui la diagonale fosse misurabile in unità uguali rispetto al lato: questo è un non-ente (eterno), e pertanto neppur esso si trova nel tempo.
- Coscienza (psuhé) – Abbiamo detto sopra che se la coscienza, ad esempio durante un sonno profondo, non coglie alcun movimento, nasce l’impressione che il tempo non scorra. Ciò significa che la coscienza è il presupposto del tempo. Ora, Aristotele si chiede espressamente “in che modo dunque il tempo si rapporta alla coscienza”. Il tempo è, nel movimento, il numero. Ci si deve chiedere se il tempo sarebbe presente “se non vi fosse una coscienza (del numero)”. Se non vi fosse nessuno “che potesse contare”, risponde, “allora non potrebbe neppure esserci qualcosa che potesse essere contato, e dunque chiaramente neppure il numero”. Ne consegue che, “se null’altro in natura è dotato della capacità di contare all’infuori della coscienza (umana), e in questa (soprattutto) la capacità intellettiva (psuhêz noûz), allora è impossibile che vi sia tempo se non vi è coscienza (di esso)”. È possibile che vi siano eventi che determinano mutamenti, ma senza che se ne sia consapevoli. “Il tempo per contro è tutto questo (solo) in quanto è calcolabile”. (Ma questo significa anche, senz’altro: in quanto è calcolato in quanto calcolabile.) Aristotele fa pensare qui, mi sembra, a Immanuel Kant. Kant afferma: “Il tempo è semplicemente una condizione soggettiva della nostra intuizione (umana) …, e in sé, al di fuori del soggetto, non è nulla”. Aristotele dice che il tempo è, solo se c’è coscienza. In proposito io dico: questo tempo soggettivo, questo tempo della coscienza secondo Aristotele, io lo chiamo – visto che l’aldilà della coscienza del soggetto non mi interessa – il tempo oggettivo, il ‘tempo-orario’ (Uhr-Zeit) – cui io contrappongo, in quanto tempo soggettivo, il tempo del vissuto o del concepire, che Aristotele non conosce.
- Tempo degli orologi – Nell’antichità l’orologio è universalmente noto, ad esempio come orologio idraulico, o clessidra o meridiana. Alla fine della sua analisi del tempo, Aristotele si domanda se lo stesso tempo ritorna spesso, e risponde: se un medesimo movimento definito si ripete, anche il tempo è lo stesso. Egli illustra ciò con l’immagine del cerchio e del “movimento circolare”, e con l’esempio dell’anno. È possibile, scrive, “che un medesimo decorso temporale abbia luogo più e più volte, e ciò vale esattamente anche per segmenti di tempo, ad esempio l’anno o la primavera o l’autunno”. “Il tempo misura il movimento in modo tale da delimitarne [mediante gli attimi] un segmento determinato [e da misurarlo in modo conforme al numero]”.
Tutto questo, aggiungo, descrive l’orologio.
Per concludere, vorrei porre una domanda: come si misura con la filosofia del tempo elaborata da Aristotele la mia affermazione secondo cui “la musica è un gioco con stimoli sensoriali nella forma di una fondazione del tempo”? In questione è l’espressione ‘fondazione del tempo’. Nonostante tutto quel che di sostanzialmente valido la filosofia aristotelica del tempo contiene, una fondazione del tempo – mi pare – non si trova in Aristotele. Per lui le condizioni perché vi sia tempo sono: il movimento, l’attimo e il numero.
Tempo vi è soltanto nel movimento.
Tempo vi è soltanto se gli attimi delimitano il movimento.
Tempo è l’unità di misura di questo delimitato.
Per Aristotele il tempo è fattore numerico nel movimento delimitato, e pertanto dipende dalla facoltà di calcolare fondata nell’intelletto umano.
Presupposto per la fondazione del tempo nel senso della mia affermazione è però che:
- si svincoli il concetto di ‘tempo’ da un tempo di decorso rotatorio “fondato nella natura”, quale che sia la sua conformazione (ad esempio il tempo planetario): ciò che io chiamo il ‘tempo degli orologi’;
- la liberazione dal tempo degli orologi sia il presupposto per la costituzione del tempo del concepire: questo tempo non è misurabile;
- il tempo del concepire del soggetto, non misurabile, è il presupposto per la fondazione del tempo soggettiva ed anch’essa non dipendente dalla misurabilità.
Il concetto di ‘tempo’ in Agostino L’esposizione che segue si limita al libro XI delle Confessioni, che contiene gli elementi essenziali della filosofia agostiniana del tempo. Mi servirò dell’edizione delle Confessioni curata da Joseph Bernhardt, con testo latino a fronte, 4a ed., München, 1980.8 Per quanto riguarda il De musica, scritto poco prima, rinvio alla trattazione di Uta Störmer-Caysa, Augustins philosophischer Zeitbegriff: ein Vorschlag zum Verständnis der distinctio animi im Lichte vom “De musica”, Berlin, Akademie, 1996 (“Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig”, philologisch-historische Klasse, 74/3). Quanto v’è nel De musica che integra le Confessioni può essere riassunto, appoggiandosi alla Störmer-Caysa, in questi termini: la creazione venne creata dal creatore dell’universo in base al numero, e di qui i numeri che valgono per la valutazione del tempo (numeri iudicales) sono impressi nell’anima; vengono però soggettivamente interpretati ogni volta dall’anima che percepisce il tempo quali numeri sensuales e recordabiles. In tal senso il concetto soggettivo di tempo di Agostino è già presente nel De musica.
Agostino dev’essere compreso partendo dall’intreccio di filosofia antica e di pervasività della fede cristiana, un intreccio in cui la filosofia costituisce la base, e la fede domina. A partire dalla dimensione cristiana si spiega, se vogliamo dirla con una formula, il riferimento al soggetto del suo pensiero filosofico, in cui il concetto ‘tempo’ occupa una posizione centrale.
Dio è nell’eternità (aeternitas). Egli ha creato il cosmo e, insieme con la creazione, il tempo. Deus creator omnium. Pertanto è sciocco chiedersi cosa facesse Dio prima di creare il cielo e la terra, perché “non esisteva un “allora” dove non esisteva un tempo.” “Senza alcun tempo non vi era tempo.”
Agostino stesso, nelle Confessioni, trasferisce la propria filosofia del tempo nell’ambito della musica, dandone appunto un’illustrazione di carattere musicale. Egli dimostra la propria risposta alla domanda “cos’è il tempo?” riferendosi al metro quantitativo di un verso, cioè al suo movimento sonoro, che provoca un’impressione sensoriale (sensus manifestus). Faccio riferimento a questa dimostrazione, perché permette di capire l’essenziale della filosofia agostiniana del tempo.
| È | _ | È | _ | È | _ | È | _ | ||
| De- | us | cre- | a- | tor | om- | ni- | um |
sono otto sillabe, alternativamente lunghe e brevi. Ne misuriamo lunghezza e brevità nel mentre che esse risuonano. Noi stabiliamo che la sillaba lunga ha la durata di due brevi (1 : 2). Ma come facciamo a sapere che nella parola Deus la sillaba De- è breve? Lo sappiamo solo quando è risuonata la sillaba -us. In quel momento però la sillaba breve De- non ha alcun è, poiché è trascorsa, non è più. Ma neppure la sillaba lunga è più, perché si afferma come lunga (2 : 1) solo quando è trascorsa. Dov’è allora il tempo, dove sono lunghezza e brevità, che non sono più allorché io percependole le misuro? È, dice Agostino, “nell’animo”, in anima, “e non lo vedo altrove.” “Dunque non misuro già le sillabe in sé, che non sono più, ma qualcosa nella mia memoria, che resta infisso.”
E ora, per ripetere il tutto in termini generali, ma con maggior attenzione all’elemento di principio (dove Agostino e Aristotele si toccano): il passato non è un ente, poiché non è più. Il futuro non è un ente, poiché non è ancora. Il tempo, in quanto ente, può essere dunque solo presente. Ma il presente trapassa costantemente in passato, e dunque nel non essere. E il futuro, siccome diviene presente, trapassa anch’esso nel passato. Dunque neppure il presente è un ente, poiché in ogni istante si divide in un arrivo dal futuro e in uno svanire nel passato. “Solo se si concepisce un periodo di tempo che non sia più possibile suddividere in parti anche minutissime di momenti, lo si può dire ‘presente’. Ma esso trapassa così furtivamente dal futuro al passato che non ha una pur minima durata [morula]. Qualunque durata avesse, diventerebbe divisibile in passato e futuro; ma il presente non ha nessuna estensione [spatium].”
Tuttavia noi percepiamo spazi temporali, li confrontiamo e li misuriamo. Ma dove sono in realtà? “Il tempo può essere percepito e misurato al suo passare.” Ma dove sono là, nel presente, visto che neppur esso è? Sono nello spirito (in animo). Il passato si trasforma in immagini (imagines), “quasi orme impresse [dai fatti] nel nostro animo mediante i sensi al loro passaggio.” Nel presente io contemplo un’immagine del passato, “poiché sussiste ancora nella mia memoria.” Ma il futuro? Qui vale il fatto che noi possiamo pensare anticipatamente, nel presente, delle immagini già disponibili del futuro, il quale però sarà solo allorché diverrà presente. Ad esempio: “Se osservo l’aurora, preannuncio la levata del sole. L’oggetto della mia osservazione è presente; quello della mia predizione, futuro; non futuro il sole, che esiste già, ma la sua levata, che non esiste ancora. Però non potrei predire nemmeno la levata senza immaginarla dentro di me come ora che ne parlo.”
Ne consegue che “i tempi sono tre:
un presente di cose passate,
un presente di cose presenti,
un presente di cose future.
Infatti questi tempi sono una sorta di triplicità nell’anima, e altrove io non li vedo; e cioè abbiamo:
un presente di cose passate, cioè il ricordo [memoria];
un presente di cose presenti, cioè l’intuizione [contuitus];
un presente di cose future, cioè l’attesa [expectatio].”
Ma come, e con che cosa, noi misuriamo il tempo? Lo misuriamo in rapporto al movimento, ad esempio il movimento del sole, della luna e delle stelle? Il tempo non è il moto dei corpi celesti. “Quando il sole si fermò” all’appello di Giosuè, “il sole era fermo, ma il tempo procedeva.” Un corpo si muove nel tempo, ma il suo movimento non è tempo. Il tempo viene misurato col movimento sulla base di paragoni. Ma con cosa lo si misura? Un segmento temporale più lungo viene misurato con uno più breve. In questo modo misuriamo la durata di una sillaba lunga con quella di una sillaba breve, come ad esempio De-us. Eccoci tornati al nostro esempio di partenza: il tempo non è da nessun’altra parte che nell’anima, in virtù della memoria. Là sorge, mediante confronti, la coscienza di lunghezza e brevità.
Ma anche questo tempo, questa misura, non ha alcuna realtà oggettiva. Infatti neppure con la durata delle sillabe “si definisce una misura costante di tempo, poiché un verso più breve può essere fatto risuonare, strascicandolo, per uno spazio di tempo maggiore di uno più lungo, che venga affrettato.” Al pari del tempo, pertanto, sono soggettive anche la misurazione del tempo e la sua misura, come ci esprimeremmo noi, mentre Agostino dice: in anima o da nessun’altra parte.
Alla fine del libro XI delle Confessioni Agostino esemplifica la propria filosofia del tempo ricorrendo ancora una volta alla musica.
“Accingendomi a cantare una canzone [canticum] che mi è nota, prima dell’inizio la mia attesa [expectatio] si protende verso l’intera canzone; dopo l’inizio, con i brani che vado consegnando al passato [decerpsero], si tende anche la mia memoria. L’energia vitale dell’azione è distesa verso la memoria, per ciò che dissi, e verso l’attesa, per ciò che dirò: presente è però la mia attenzione, per la quale il futuro si traduce in passato. Via via che si compie questa azione, di tanto si abbrevia l’attesa e si prolunga la memoria, finché tutta l’attesa si esaurisce quando l’azione [actio] è finita e passata interamente nella memoria. Ciò che avviene per la canzone intera, avviene anche per ciascuna delle sue particelle, per ciascuna delle sue sillabe, come pure per un’azione più lunga [in actione longiore] di cui la canzone non fosse che una particella; per l’intera vita dell’uomo, di cui sono parti tutte le azioni dell’uomo; e infine per l’intera storia dei figli degli uomini [in toto saeculo filiorum hominum], di cui sono parti tutte le vite degli uomini.”
Confrontiamo ora con Agostino la nostra tesi, che suona: la musica, mentre risuona, non consuma o utilizza o pretende tempo, bensì lo pone, lo crea, fonda un tempo che non c’è al di là di questa fondazione – un tempo che c’è solo mediante questa fondazione: come tempo di questa fondazione.
Ciò vale, per Agostino, per il tempo in generale. Esso è nella creazione del creatore. Ma esso non è nell’orologio, né nel moto degli astri, ma è in via di principio nell’anima dell’uomo, e in nessun altro posto. E nell’anima umana esso può, anche quando lo si misuri, essere non universalmente vincolante, ma solo di volta in volta, solo nell’irripetibilità dell’individuo, del soggetto. La musica non fa qui eccezione, bensì è proprio con essa che Agostino dimostra quanto ha affermato. L’anima, il ricordo come facoltà dell’anima, fonda nel movimento la coscienza del tempo.
Questo contraddice il mio assunto circa l’oggettività del tempo degli orologi. Per Agostino anche il tempo degli orologi c’è solo come fondazione dell’anima. Tuttavia nella mia teoria del tempo il tempo musicale è contrapposto al tempo degli orologi in quanto tempo che decorre in sé e per sé, in cui l’uomo è irretito come in una ruota che gira su sé stessa, dalla quale può liberarlo la musica in quanto fondazione di un tempo situato al di là della ruota.
Ma questo, per quanto posso vedere, è solo un percorso indiretto che conduce ad Agostino – una via indiretta che aggira l’orologio in quanto potere sulla vita che dev’essere evitato. Infatti io affermo che la musica “in quanto gioco con stimoli sensoriali nella forma di una fondazione del tempo” può dirci, sul sentiero della aísthesiz, quel che il tempo in genere dovrebb’essere nella nostra vita: non un tempo regolato dagli orologi, che, nello scorrere, ci domina, bensì fondazione del tempo, tempus in anima, tempo che noi creiamo mediante noi stessi.
Credo che la riflessione di Agostino sul tempo possa servirci come testimonianza di quest’idea.
(Traduzione dal tedesco di Maurizio Giani)
- 5) Un’eccezione è rappresentata da un accenno contenuto nell’interpretazione della fiaba proposta da Klaus Weimar, cui faremo riferimento più avanti.
- 6) La traduzione riproduce, con diverse modifiche, quella di Bonaventura Tecchi in W. H. Wackenroder, Scritti di poesia e di estetica, Firenze, Sansoni, 1934, pp. 137-142.
- 7) Vedi in proposito K. Weimar, Versuch über Voraussetzung und Entstehung der Romantik, Tübingen, Niemeyer, 1968, p. 70: “Solo una nuova modalità di manifestazione del tempo, e una nuova esperienza del tempo, può salvarlo [scil. il santo ignudo]: la musica … costruisce nel tempo … un suo proprio sistema temporale”.
- 8) La traduzione riproduce quella di Carlo Carena in Agostino, Le confessioni, a cura di M. Bettetini, trad. di C. Carena, Torino, Einaudi, 2000.