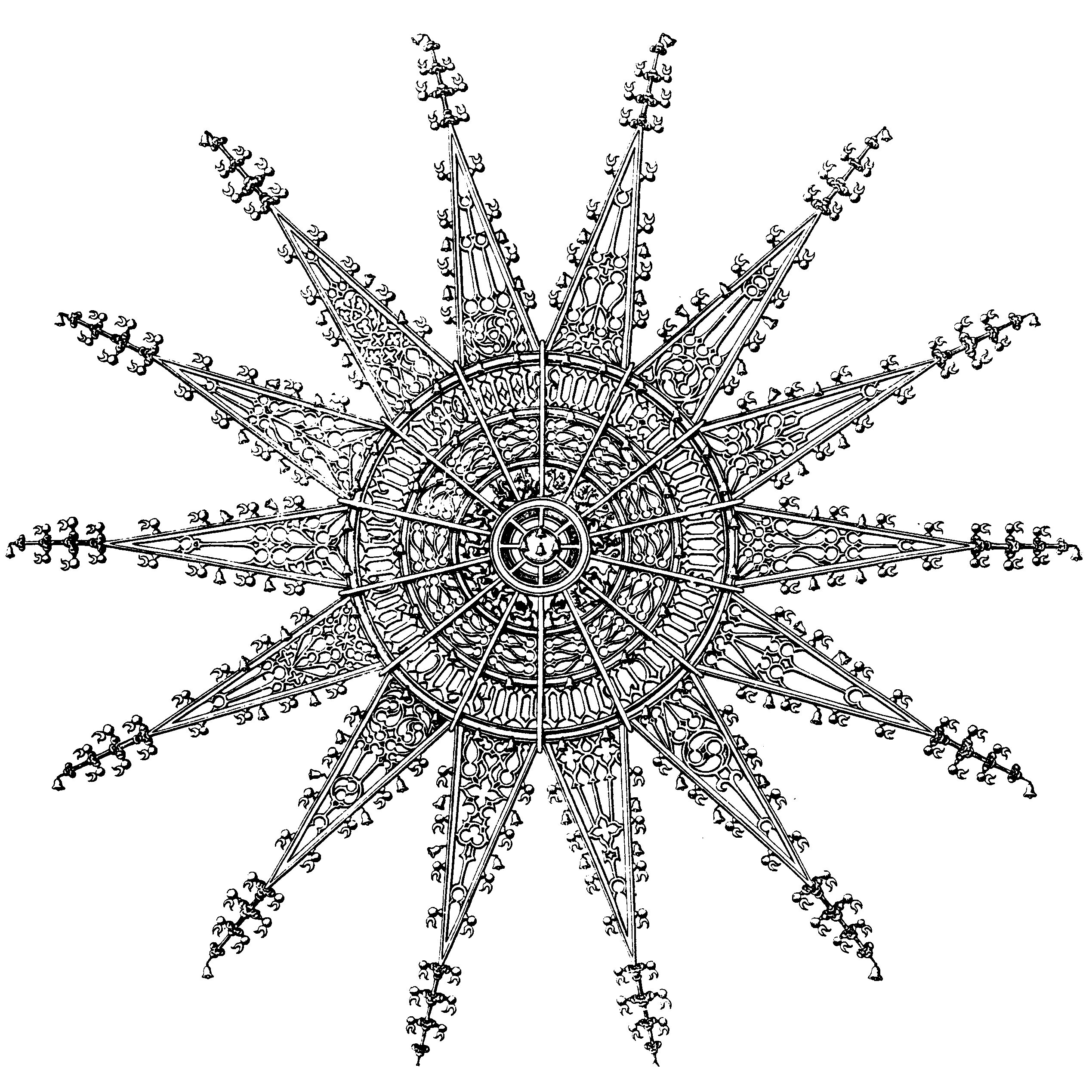Il selfie, al di là della sua cattiva fama, in parte giustificata dagli usi quanto meno spregiudicati che troviamo in rete, può avere in sé potenzialità sia creative che riparative. Anche sotto questo profilo la funzione del destinatario ha un ruolo fondamentale, ma qui voglio soffermarmi su un aspetto particolare della questione. Il selfie, nella sua dimensione corrente, è caratterizzato dalla occasionalità e dalla condivisione in rete. In molti casi non prevede particolari implicazioni psicologiche e sostituisce semplicemente la vecchia cartolina o l’autografo: il bisogno di far sapere che siamo stati in un posto particolare, il piacere di dimostrare di essere stati accanto a un personaggio famoso, ecc. Più interessante il fatto che esso preveda una risposta da parte della rete: questa esigenza di condivisione, anche quando si limita a un bisogno di visibilità e approvazione, è qualcosa che può essere considerato sia (ciò che avviene di solito) come un sintomo di fragilità narcisistica sia come una necessità di relazione, che passa comunque attraverso il rapporto con l’immagine di sé: immagine di sé che viene esplorata, proposta, messa in gioco anche con ironia e creatività, secondo una antica vocazione dell’autoritratto, di quello fotografico in particolare.
Ma ora ho in mente una tipologia di selfie per certi aspetti più interessante: quello fatto da soli, che inquadra soltanto la nostra immagine, eseguito però in luogo pubblico – un selfie scattato in uno spazio privato assomiglia troppo a un autoritratto tradizionale con quanto di progettato vi può essere in esso. Quello di cui parlo ha, come tutti i selfie, un carattere di occasionalità (legata al luogo, al momento, allo stato d’animo) ma implica dinamiche più profonde e complicate rispetto a quello che sostituisce la cartolina o l’autografo. Paola Mastrocola in un articolo sul «Sole 24 ore» del luglio scorso ci fornisce una descrizione efficace della situazione:
«Prendiamo un ragazzo, sui venticinque anni. È seduto sul gradino di un parco. Jeans e maglietta. Capelli biondini, corti. Di colpo estrae il cellulare e se lo mette davanti al viso. Un po’ in alto. Lo tiene in alto sulla propria testa, col braccio teso e clic, si fa la foto. Io non so, ma credo che sia quel braccio teso. Propaggine di noi, che non si stacca da noi. Diverso dall’autoscatto, dove la macchina è lontana, è fuori da noi. Qui lo strumento che ci fotografa è legato al nostro corpo, è parte di noi. È come se in noi fosse presente il meccanismo stesso, la macchina che ci fotografa. È diverso. Ma non so se sia quel braccio teso che mi provoca un leggero disagio, una punta di malessere. No, non è il braccio. È che quel ragazzo si sorride».
Cosa significa dunque questo “disagio”, questo “malessere”, dove sta lo scandalo di quel sorriso? Paradossalmente, ritengo che proprio in questa capacità di ritagliarsi, in pubblico, uno spazio per sé e dedicarsi un sorriso stia la forza, la creatività di questi selfie solitari. Esiste tutta una tradizione di ritratti e autoritratti “dedicati”, in cui lo spessore psicologico del gesto passa attraverso il peso della relazione con l’altro. L’eccezionalità di questi selfie auto dedicati – che di per sé non sono destinati alla rete – sta nel fatto che qualcuno riesca, per un momento, a isolarsi e a ricavarsi uno spazio tutto per sé, pur avendo, in fondo, la consapevolezza di essere di fronte a un pubblico virtuale. In qualche misura quel pubblico, con il suo possibile disagio, è anzi il presupposto e forse il referente di questo “occasionale” progetto, nel momento in cui quel sorriso tornerà a essere qualcosa di socialmente condiviso.
Stefano Ferrari
Professore associato di Psicologia dell’arte
Dipartimento delle Arti – Università di Bologna