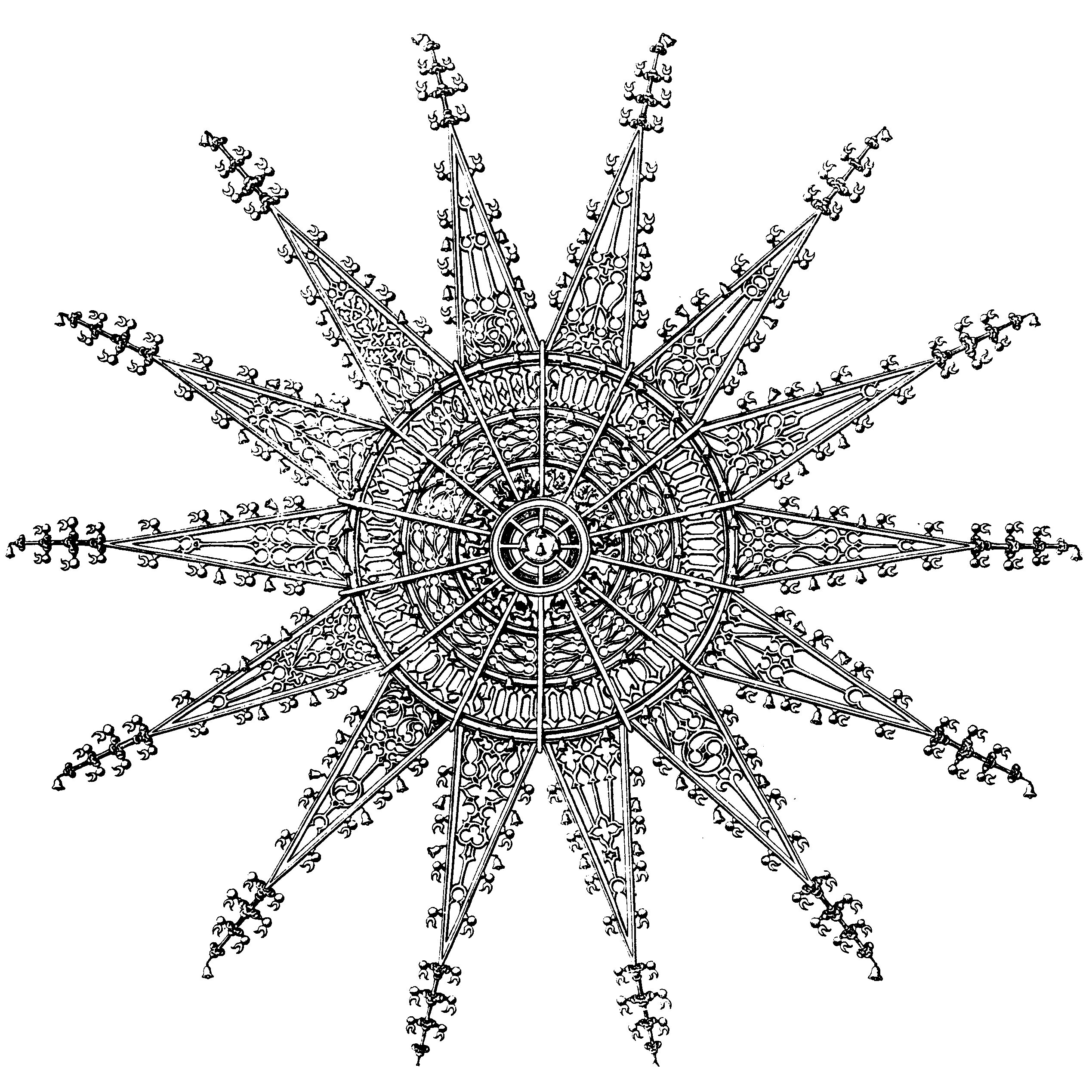Daniela Piana
Indaco. A tratti violaceo. Il cielo che promette vento e rigido sole. Traversa le finestre ovali la luce tagliente senza essere belligerante. Anzi. Pace. Questa la parola che apre l’inaugurazione del Padiglione Camerun “Nessuno è profeta in patria” a Venezia, Palazzo Donà dalle Rose.
Scegliamo. Quale forma dare alla rappresentazione di noi, che ci siamo e che siamo nel mondo, nei luoghi che apriamo a chi porta sé stesso. “Stranieri ovunque” perché non ci guardiamo con gli occhi di chi riconosce in primo luogo di essere fragili frammenti di una vita che pulsa tra e oltre le generazioni e le civiltà, e ci rende unici eppur transeunti.
Nell’anno che appare volerci socchiudere la porta del futuro, la Biennale di Venezia titola il proprio palcoscenico “Stranieri ovunque”. Come se le modalità di pensare le frontiere andassero riviste e le arti nei loro linguaggi ci aiutassero a stabilire modi per sentirci meno stranieri innanzitutto a noi stessi.
Il Padiglione Camerun intarsia qualcosa di più. Nessuno è mai profeta in patria forse perché al profeta consta l’arduo compito, eppur ineludibile, di rappresentare il futuro oggi, e di farlo traendo ispirazione da un altrove che non può essere patria. La patria non ti riconosce. Non nella sincronia, quantomeno.
Così il padiglione del camerunense ospitato a Palazzo Donà dalle Rose sulle Fondamenta Nuove di una Venezia che apre le porte alla sessantesima edizione della biennale è metafora significante di una abalietās e di una estraneità che, insieme, ci dicono tanto del rapporto con l’altro, che questa nostra epoca di trasformazioni di paradigma – grammaticale, semantico, pragmatico, e simbolico – ci porta a vivere e preconizzare.
Metafora.
Nelle alternanze di palcoscenico e di rappresentazione che offre l’entrata nel padiglione – ed è già teatralità – lo sguardo è indotto a cercare un senso sia nel palcoscenico, sia nella rappresentazione.
A contatto con una alterità culturale linguistica carica di storia, chi entra si immerge in una sorta di esercizio di traduzione. Sul piano epistemologico è una sfida epocale. È la nostra sfida. Il rapporto con l’altro, preso sul serio.
Si tratta di una grammatica generativa di significati sociali come quando si parla una lingua che si protende verso la comprensione degli altri e del modo con cui ognuno crea significati che diventano “noi”.
Ci accoglie una musica fatta da strumenti di percussione. La percussione che apre la performance musicale della biennale è una reductio ad un ritmo di battito. Il cuore? Più ancora i giovani talenti che si susseguono sullo stage del Palazzo, con il backstage d’eccezione della laguna intravista sull’ombra fluttuante del crepuscolo gelido e trasparente, sono una scintilla del non detto che fa da luce interiore a tutto ciò che è aspirazione-talento-speranza-desiderio di immaginare un mondo diverso. Ma non rompendo col passato, al contrario, traendo dalla storia, dall’arte, la radice: “libri” radicali, nel senso in cui Carlo Ossola ci riporta dopo il confinamento a quattro libri senza tempo sulla dignità dell’essere persone. Carlo Ossola scrive della difficoltà di proiettarsi nel futuro e della necessità di avere un ritorno al riconoscimento della alterità. Torna alla memoria una sua frase quando si entra al Padiglione Cameron. Fare l’esperienza. Esserci. In uno spazio che performa la visione altrui del mondo e dell’esserci nel mondo.
Presenza.
Ovunque stranieri. Le arti che popolano la biennale in questo anno già proiettano verso la BIAS, Biennale internazionale di arte sacra contemporanea, dove la segmentazione dei loci in cui la rappresentazione artistica ha luogo è data sulla base di una visione non per stigmatizzate formalizzate differenze, quanto per grandi fiumi carsici ed emergenti di culture: ognuna delle quali declina il sacro nel proprio linguaggio e con quello dà un senso sì di appartenenza, ma soprattutto già tratteggia la forma della porta che apre all’alterità.
Perché questa è la grande sfida che abbiamo dinnanzi. Coniugare appartenenza e apertura alla alterità senza sapere quale essa sia e soprattutto quale essa sarà.
È grazie a queste intuitive immaginazioni e a queste sapienti costruzioni dell’intelletto che sapremo andare verso il nuovo che chiama. Non dicotomia “comunità chiusa” versus “società aperta”, ma apertura che si fa e si dà perché una forma consapevole di pluralismo riflessivo si mette in atto. Cosa è il pluralismo riflessivo? È una visione promossa da Rosenfeld quando guarda a come agiscono ed elaborano le norme le corti supreme bilanciando diversi principi, facendolo in modo chiaramente motivato ed esplicito nella scrittura.[1] Per arrivare a quella esplicitazione occorre un distanziamento riguardo sia all’uno sia all’altro dei diversi principi, in modo che se ne veda le potenzialità di dia-logos con gli altri.
Può apparire una traiettoria di pensiero inusuale ed inconsueta quella di prospettare ponti fra la rappresentazione scenica, la musica, la alterità che si materializza in uno scenario di eccezione come quello della laguna, da sempre crocevia eppur fondamenta – vecchie e nuove – di culture che riverberano la loro ricchezza attraverso la lingua del viaggio e di ciò che sta alla base di tutto: il primato della regola del diritto de iure condendo, il diritto che si fa nella società. Così come detta, allora questa ricchezza è al contempo savoir vivre avec les autres ma senza sapere ex ante chi gli altri saranno. Una sapienza che, infusa nell’arte, permette di veicolare significati aperti, che si danno e si determinano a contatto con l’alterità, giammai predeterminata (è il vocabolo giusto?) nella sua origine e identità, ma declinata nella realtà dell’essere hic et nunc.
Il trait d’union con la Biennale internazionale di arte sacra contemporanea è già nelle cose, fra radici del futuro e ceneri del futuro, che nel presente ritmano il loro ‘ora’ e ‘adesso’; è tempo di immaginare il rispetto dell’altro non solo nel laissez vivre, ma nell’accogliere con un emiciclo, un mezzo cerchio, metafora dell’abbraccio e della libertà.
La forma della bellezza incarnata nella materia ci appare e ci meraviglia se la persona è resa libera di esaltarne la nascosta parola, la silente immagine, la potenza di ciò che nasce già irrorato dall’acqua del passato e che si proietta verso un futuro donato a chi verrà. La magia sta nell’incontro. Fra storia ed immaginazione, fra materia e spirito, fra il saper fare e il poter fare.
Ovunque nel pianeta voci chiedono di avere l’opportunità di contribuire al dialogo fra culture e fra le loro radici. Di essere e dare meraviglia. Solo se le arti e le conoscenze saranno da tutti per tutti, il nuovo mondo avrà la trama dell’incanto, il fuoco del sacro già portatore del dono.
[1] Michel Rosenfeld, Just Interpretations. Law between Ethics and Politics, University of California Press, Berkeley – Los Angeles – Oxford, 1998.